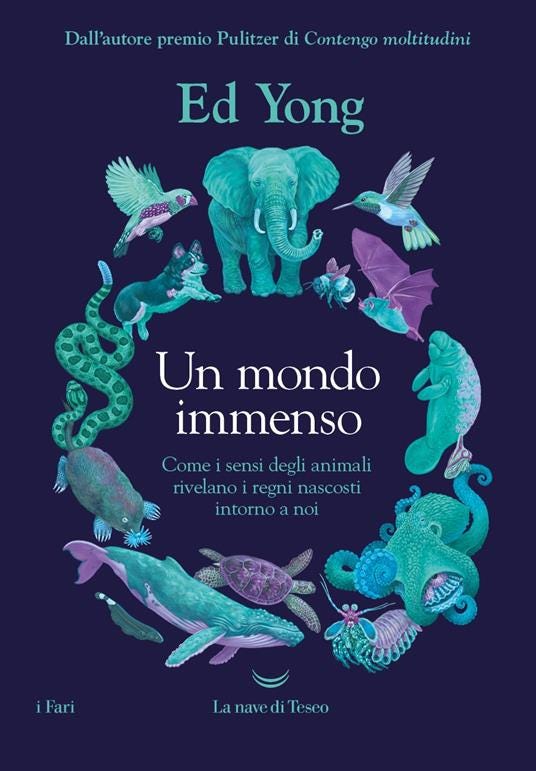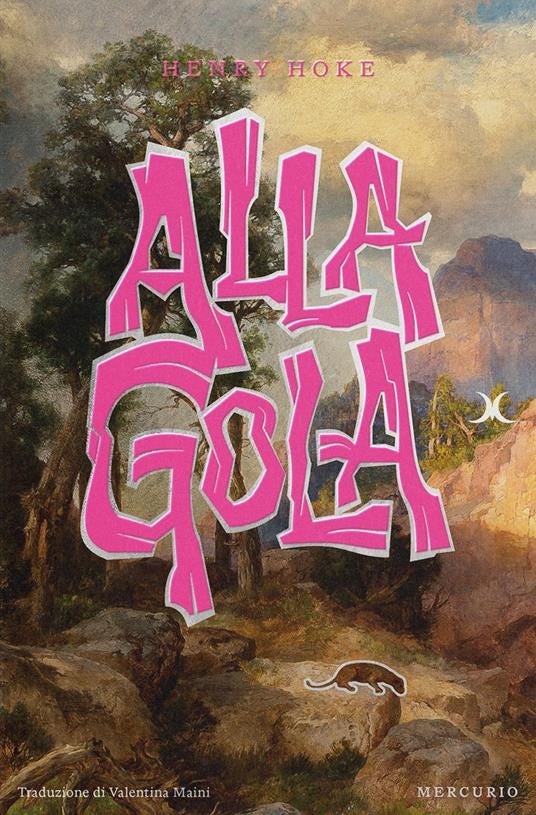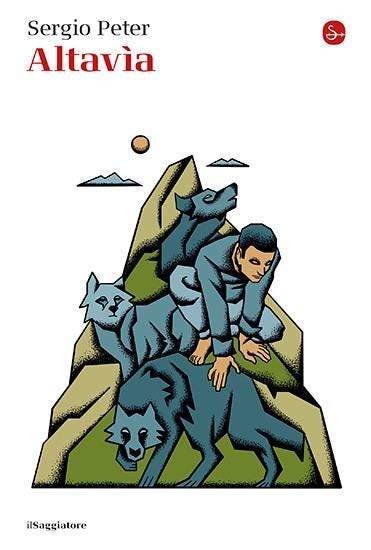Reimparare ad annusare l’aria che tira
per riconoscere il fetore di un mondo che brucia
Per molto tempo, sono andato a letto presto la sera… e continuo con questa “proustiana” abitudine. Probabilmente per il fatto che mi piace alzarmi all’alba, soprattutto d’estate, e farmi una corsetta prima di cominciare la giornata. Piccola per carità, con andatura lenta, quando non c’è nessuno in giro. Al massimo incrocio qualcuno che passeggia con il cane.
E quando corro i pensieri scorrono: «Quanta pazienza deve avere un cane che cammina al vostro fianco!» Verrebbe naturale pensare il contrario, da bravi antropocentrici, ma dal punto di vista del cane, queste passeggiate devono sembrare terribilmente noiose: lineari, senza alcuno scopo reale. Per i cani, non si tratta semplicemente di attraversare i luoghi, ma di esplorarli. Il loro modo di muoversi è spesso erratico, non segue una traiettoria precisa. È il loro olfatto a guidare il passo, a costruire un’immagine del passato, del presente e forse anche del futuro di un oggetto, di un luogo o di un incontro. È proprio l’olfatto a definire la loro percezione del mondo, che è molto diversa dalla nostra, che invece è più visiva.
L’ho imparato fin da piccolo quando tentavo invano di fare gare di corsa con Billy, il nostro velocissimo bastardino: pochi metri dopo la partenza deviava il percorso attirato da qualsiasi cosa. Dall’altro canto però le mancate gare con Billy mi hanno insegnato a osservare ciò che solitamente non si nota: mentre l’umano è in una trappola sensoriale, intento a non guardare oltre lo schermo del proprio cellullare, a non ascoltare fuori delle proprie cuffiette, il cane che è con lui continua ad usare l’unico senso che non si può smettere di usare: l’olfatto. Nessuno può smettere di annusare ad ogni respiro, neanche l’umano in trappola sensoriale. Casomai l’uomo ha imparato ad ignorarlo.
Recentemente mi sono imbattuto in “Un mondo immenso” (La Nave di Teseo, 2023) di Ed Yong, libro che ci invita a mettere in discussione il nostro senso principale, la vista, e ad avvicinarci allo studio dei mondi percettivi degli animali non umani. È un modo per scoprire quanto il loro modo di percepire il mondo sia diverso e affascinante rispetto al nostro.
Sorprendentemente nell’ultimo periodo mi è capitato di leggere anche altri libri “anti-specisti”, come “Alla gola” dello scrittore americano Henry Hoke, (tradotto da Valentina Maini per Mercurio).
«Non ho mai mangiato una persona ma oggi potrei farlo» con queste parole si apre il libro di Hoke e il monologo del puma protagonista che vive nel luogo simbolo dell’immaginario occidentale e della sua costruzione, le colline attorno a Hollywood, devastate dai cambiamenti climatici che rendono tutto arido e difficile la sopravvivenza.
La particolarità di questo libro è il modo originale con cui viene narrata la storia: Hoke infatti decide di raccontare tutta la vicenda attraverso lo sguardo e le sensazioni del puma protagonista che osservando ogni giorno i turisti e gli escursionisti che scalano la collina, ascoltando le loro parole e studiando i loro gesti inizia a pensare e osservare il mondo con uno sguardo ibrido. A metà tra un uso dei sensi tipicamente animale, quindi usando soprattutto l’olfatto che lo spingerebbe “alla gola” dell’essere umano, e l’atto di osservarlo e ascoltarlo nella sua stupida tendenza verso l’autodistruzione. Interessante e originale, vero?
Ora come ora sto finendo di leggere “Altavìa” di Sergio Peter (il Saggiatore) dove si narra di tre amici che, spinti dall’enigmatico Guido Caviezel, si avventurano tra le Alpi: Filo, visionario gigante buono, il Bosceta, giovane mistico amante del jazz, e Sergio, superstite di un passato oscuro. Mediante una ricerca sui lupi cercano di risintonizzarsi con un mondo in cui non si riconoscono più.
E lo fanno attraversando luoghi selvatici, posti dove i protagonisti cercano la riconnessione con la natura, che forse non potrà mai avvenire fino in fondo, ma si augurano che, grazie ad una ibridazione dei sensi, li aiuterà re-interpretare un mondo che così com’è risulta incomprensibile.
«I lupi usano un linguaggio non verbale, fondato sulla deposizione di feci e sulle predazioni. Ci ho messo un po’, ma alla fine ci sono arrivato.» … Replichiamo il loro sistema di comunicazione: grattarci la schiena sulla corteccia, strusciarci a pancia in su, sfregare il naso nella terra, sbuffare. «Finiremo per somigliare alle bestie, corpi lerci pieni di erba e sciao.» … «Se non ci è concesso di incontrarli direttamente, è necessario adeguarci al loro idioma. Comunicare a distanza.»
Quando corro i pensieri scorrono: «Quanto stupido è spendersi a cercare altre forme di vita nello spazio quando contemporaneamente abbiamo accresciuto esponenzialmente la nostra incapacità di comprendere le specie animali che camminano al nostro fianco in questo pianeta.»
Lo “sterminio biologico” attuale non è solo la perdita di qualche specie, significa anche la sparizione di forme di vita con altri modi di guardare il mondo. O di annusare il mondo.
Come dicevo mi piace alzarmi all’alba e farmi una corsetta prima di cominciare la giornata. È un modo per rimettere in moto i muscoli, ma anche per riattivare i sensi. Nella scelta del percorso ho imparato a farmi cane: annuso l’aria per evitare lo smog delle auto, i solfiti sparati sulle viticolture, il fumo delle “plastiche” bruciate (sì, appena fuori dei centri abitati c’è ancora chi brucia rifiuti la mattina presto, quando nessuno li vede) …
Annuso l’aria e devio il percorso secondo ciò che mi racconta il naso, anche se annusare è ormai diventato difficile, disorientati come siamo in infinite trappole sensoriali. Che ci attirano come falene verso la fiamma di un mondo che sta bruciando e di cui non riconosciamo più il fetore.