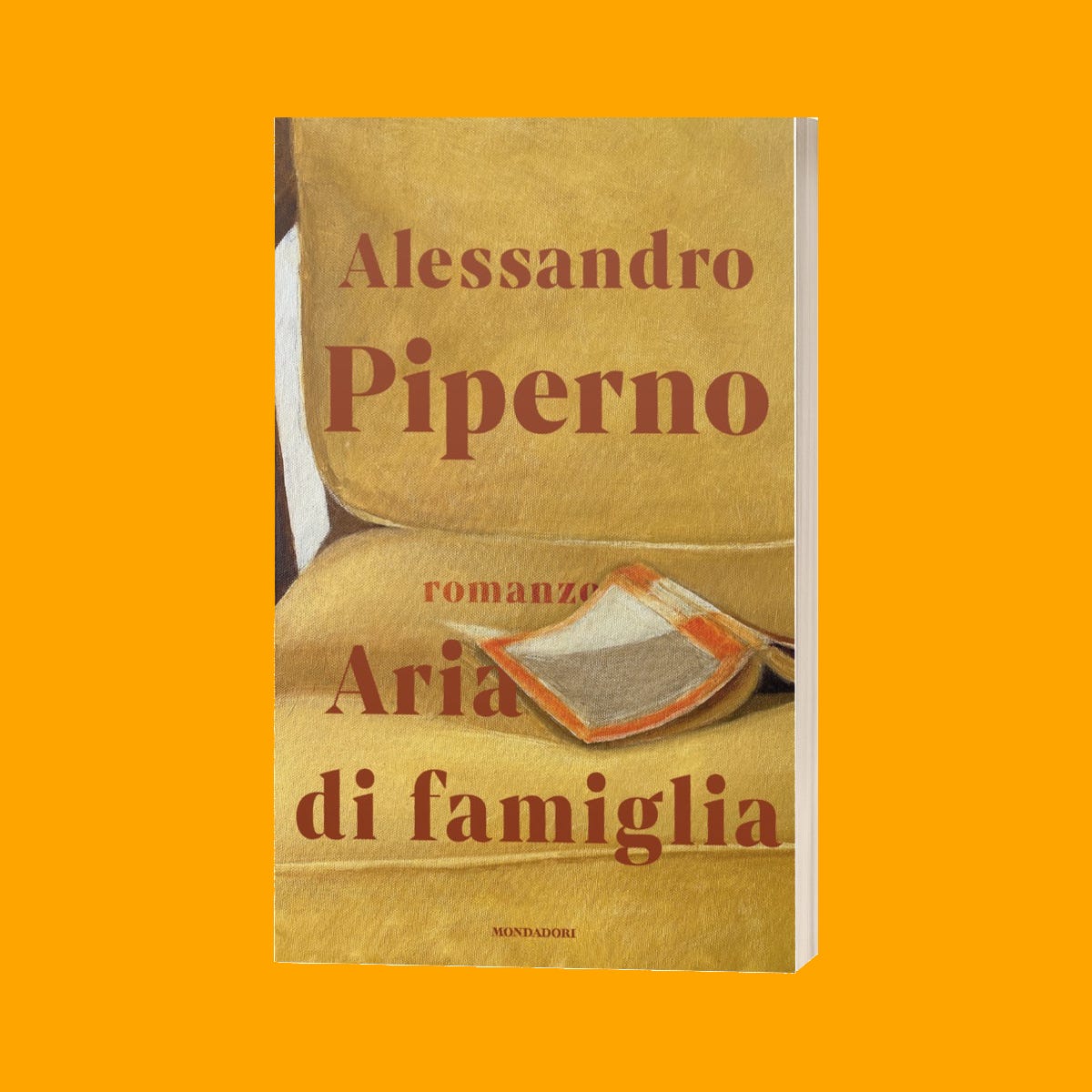Seduzione vs sedazione
"Aria di famiglia" di Alessandro Piperno
Sono un lettore. Non so se sono un lettore forte, leggo sicuramente meno di quanto vorrei, e lo faccio soprattutto “dondolato dal vagone” nella mia vita di pendolare. Comunque sono circa tre libri al mese, e prediligo l’editoria indipendente o nomi che non conosco. Però ci sono alcuni autori con cui sono in “fissa” senza sapere bene il motivo.
Ad esempio la mia smania nel leggere i romanzi di Alessandro Piperno non capisco da dove derivi. Probabilmente, oltre che dalla sua raffinata scrittura, viene dalla curiosità di conoscere quel mondo borghese che descrive sempre in maniera sublime. O forse, al contrario, proviene da quel mondo proletario in cui sono cresciuto e che mi ha insegnato a disprezzare la borghesia. Boh, fatto sta che quando comincio la lettura provo sempre un certo fastidio nei confronti dei protagonisti dei suoi libri, per poi trovarci invece degli sprazzi di inaspettata umanità. E questo “inaspettato” solitamente avviene quando questi si rendono conto di quanto ipocrita possa essere il mondo borghese in cui vivono.
Vecchia piccola borghesia per piccina che tu sia/ Io non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. - cit. Claudio Lolli
Avendo letto da qualche parte che il suo ultimo libro è un romanzo di formazione per ultra-cinquantenni (come me) non ho saputo resistere.
Il protagonista di “Aria di famiglia”, ovvero il professor Sacerdoti, docente di letteratura francese e scrittore, è uomo vagamente misantropo e senza figli, diventa padre accidentalmente e involontariamente, perché costretto suo malgrado ad adottare un bambino di otto anni.
Il romanzo si apre dunque con un’azione disciplinare nei confronti del Professore che avrà come principale conseguenza la sua cacciata dall’Università. Temi come la “cancel culture” o come la pervasività dei social si intrecciano nella narrazione alle vicende del protagonista, lacerando la vita di questo figlio di altri tempi.
Quando si avvia a vivere di rendita il resto dei suoi anni grazie alla vendita di una vecchia casa di famiglia ecco che arriva l’imprevisto che cambia il gioco: Noah, nipote piombatogli in casa, costringendolo a ripensare tutto.
Inaspettatamente un uomo che si sente fuori dal tempo, ormai abituato alla sedazione, al “buen ritiro”, deve cominciare a riaversi, a vivere. Con quella felice disperazione che un figlio porta con sé.
Le preoccupazioni, le responsabilità, le delusioni… ma anche le conquiste, le condivisioni, l’aria di famiglia…
Noah aveva gusti musicali anacronistici. La passione più recente erano i Talking Heads… il territorio di esplorazione di Noah non oltrepassava i Talking Heads o gli Smiths. Quando Denise gli imponeva l’ultimo trapper tatuato e la nuova band K-pop, Noah la guardava dall’alto in basso con un misto di severità e compassione. A unirci era anche questo.
Alla fine del romanzo, dopo l’allontanamento di Noah dalla sua vita, troviamo il professor Sacerdoti di nuovo solo, di fronte a una tastiera “in bilico tra piacere e disperazione”.
Ecco il fastidio (invidia?) che provo verso la vita borghese: quel poter permettersi di scegliere una vita di sedazione, un “buen ritiro”. È cosa che dura poco perché capisci, anche da libri come questo, che la seduzione vitale arriva sempre assieme a quella felice disperazione qui così ben raccontata. Mai dalla sola sedazione.
*******************
Ps) resta al borghese ultra cinquantenne quella possibilità di scelta che al proletario è preclusa: quella del “buen ritiro”. Porca miseria!